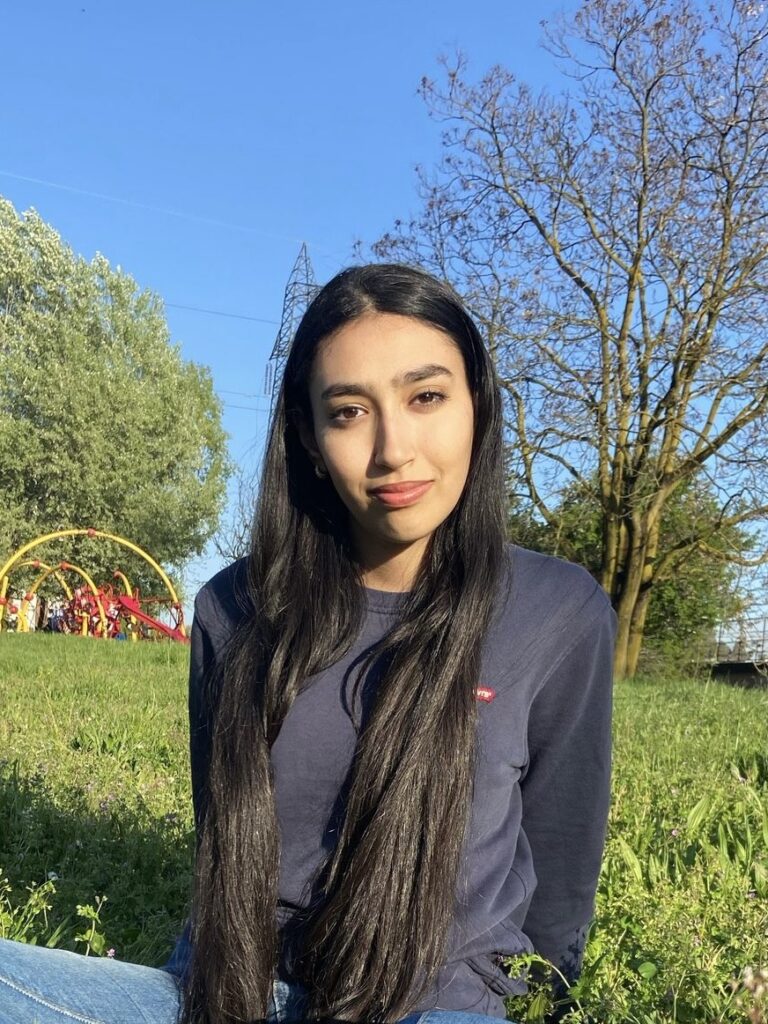Al Liceo scientifico delle scienze applicate Maxwell di Milano, una traccia di tema da parte della Prof.ssa Martire sul significato di cittadinanza oggi – riconosciuta come diritto umano universale e al contempo trasformata in un percorso a ostacoli – trova la risposta della studentessa Marwa Karkouri della 4d, 18 anni, amante delle scienze e delle persone, con il tema “Noi non siamo metà e metà, siamo interi due volte“.
Pubblichiamo le parole di Marwa a 50 giorni dal Referendum Cittadinanza dell’8-9 giugno, con l’invito alle e ai docenti da tutta Italia di ispirarsi alla traccia proposta per lavorare in classe (o di crearne una propria), a studentesse e studenti di mandare le proprie riflessioni, a tutte e tutti noi di leggere nella profondità di questo testo l’esigenza di fare tutto il possibile per raggiungere il Quorum e migliorare questa legge obsoleta.
Noi non siamo metà e metà, siamo interi due volte.
Esiste un paradosso nel modo in cui l’umanità concepisce se stessa: da un lato, proclama l’universalità dei diritti umani e dall’altro, continua a erigere muri, fisici e mentali, che dividono popoli e culture. Questo contrasto si riflette nel concetto stesso di cittadinanza: se tradizionalmente legata ad un passaporto o ad un confine, oggi dovrebbe trasformarsi in un’appartenenza più profonda, radicata nell’umanità condivisa.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 incarna questo ideale affermando che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Eppure, come dimostrano le contraddizioni della storia e le esperienze personali di milioni di persone, tra cui la mia, quel principio resta spesso un’utopia. Proprio questa tensione tra ideali e realtà emerge con forza quando si guarda alla storia dei diritti umani. Ad esempio, John Locke, teorizzando i diritti naturali: vita, libertà e proprietà, non immaginava certo che, secoli dopo, quelle stesse parole sarebbero state usate per giustificare il colonialismo e la schiavitù.
È il paradosso della storia: i principi più nobili vengono distorti per poi legittimare le oppressioni più crudeli. Proprio durante l’Illuminismo, tuttavia furono gettate le basi per un cosmopolitismo, che avrebbe ispirato nei secoli successivi la creazione di istituzioni globali come ad esempio l’ONU. Eppure, la realtà mostra come quei principi siano stati traditi: colonialismo, apartheid e leggi razziali dimostrano che l’universalità dei diritti è stata spesso un privilegio e non una garanzia.
Oggi, mentre l’Occidente celebra la democrazia, milioni di persone fuggono da guerre finanziate proprio da quelle nazioni che si professano paladine dei diritti umani. Inoltre, sempre più, nella società odierna, si parla di organizzazioni come Amnesty International, che denunciano torture, persecuzioni e repressioni, anche se le coscienze collettive sembrano assuefatte.
Quante volte abbiamo sentito dire “sono problemi loro”, come se il dolore avesse un confine? A rendere ancora più stridente questa contraddizione è il fenomeno della globalizzazione, con i suoi flussi di persone e idee, che avrebbe dovuto renderci tutti i cittadini del mondo e, invece, non ha cancellato le contraddizioni, ma ha solo reso più visibili le ingiustizie. Molti continuano a negare questa realtà preferendo chiudersi in identità rigide.
La scienza, d’altra parte, ha cancellato ogni dubbio: alcuni studi del DNA hanno dimostrato che veniamo tutti dallo stesso angolo d’Africa e che siamo tutti discendenti da un gruppo di Homo Sapiens, partito 7o.ooo anni fa e, da quel momento, quel viaggio, dettato da carestie e curiosità, non si è mai fermato, dalle steppe dell’Asia alle Americhe. Inoltre, un fatto è certo, le migrazioni hanno plasmato la storia dell’umanità molto più che le guerre. Nonostante questa verità, c’è ancora chi crede nel mito della purezza culturale, come se le identità fossero monoliti immutabili e non fiumi in continua evoluzione.
Proprio questa tensione tra connessione globale e frammentazione identitaria emerge con forza nella mia esperienza personale. Mio padre, sin da quando ero piccola, mi leggeva le poesie di Mahmoud Darwish, ma, solo crescendo, ho compreso il verso: “Ogni volta che il tramonto mi bacia, dico: io sono straniero e aumento la distanza tra me e il luogo “. Queste parole parlano della condizione di chi, pur amando una terra, ne avverte l’estraneità. E’ lo stesso senso di spaesamento che provo quando mi chiedono “Ma ti senti più italiana o marocchina?” come se l’identità fosse una scelta obbligatoria. Darwish insegnava che l’esilio non è una condanna, ma una lente per guardare il mondo senza pregiudizi, proprio come la cittadinanza planetaria richiede di superare i nazionalismi, la sua poesia invita a vedere nell’ibridazione una ricchezza.
Questa doppia appartenenza, vissuta come una ferita, segna la vita di molti figli di immigrati, noi portiamo addosso questa doppia assenza. In Italia ci chiedono da dove veniamo “davvero” e nei nostri paesi d’origine ci guardano come ospiti di passaggio. Eppure, questa condizione ci rende testimoni di una verità più grande: le culture non sono gabbie, ma lingue che si possono imparare, cibi che si possono mangiare, esperienze diverse che si possono fare e molto altro ancora. Noi non siamo metà e metà, siamo interi due volte.
A riguardo Darwish scriveva: “Io sono di lì, ho molti ricordi e come tutti gli esiliati: mescolo il presente con il passato e mi perdo tra due paesi”. In questi versi si coglie l’essenza di chi vive tra mondi diversi: il “lì” non è solo un luogo geografico, ma un insieme di radici, suoni e memorie che definiscono l’identità. Per me, quei versi hanno significato riconoscere che la mia appartenenza non era un’equazione matematica (metà e metà), ma piuttosto un mosaico di esperienze diverse.
Proprio questo riconoscimento della complessità identitaria ci porta al cuore della sfida odierna. Il grande dilemma del nostro tempo è riconciliare la cittadinanza nazionale e quella universale. Ma quindi, come si fa a rendere compatibili l’appartenenza a uno stato e il riconoscimento dei diritti che trascendono ogni bandiera?
La risposta secondo me sta nella tolleranza, intesa non come passiva accettazione, ma come impegno attivo a comprendere l’altro. Questo significa ascoltare storie diverse dalla propria, interrogarsi sulle radici dei pregiudizi e trasformare la paura in curiosità.
Non a caso la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani parla di “libertà, giustizia e pace nel mondo”, valori che restano vuoti, retorici, senza una cultura del dialogo, incarnata nell’azione quotidiana. Per tradurre questi principi in realtà, serve educare le persone alla complessità, spiegando che la storia umana è un intreccio di migrazioni e che le identità sono per natura ibride. Inoltre, è da considerare che la forza di una società si misura nella capacità di integrare, non di escludere. In questa prospettiva, le parole di Darwish risuonano come un monito e una speranza.
Forse la vera cittadinanza non sta in un documento, ma nella capacità di sentire le ferite degli altri come se fossero le proprie. Altri versi che ho sentito spesso sono i seguenti: “ La terra ci stringe, restringiamoci per farle posto”.
Quello che il poeta vuole trasmettere è un appello alla solidarietà: l’umanità che invece di dividersi in confini, si stringe per accogliere tutti. Per me, questo significa che l’integrazione non è assimilazione, ma è la creazione di un nuovo “noi”, dove le differenze dialogano.
Dunque, vivere tutti insieme, indistintamente da sesso, razza, nazionalità e religione è possibile perchè, prima di essere cittadini di un certo stato, siamo cittadini del mondo e le due cittadinanze (nazionale e planetaria) possono, anzi sono e dovrebbero essere compatibili perchè i confini, prima che sulle mappe, esistono nella testa delle persone, ed è proprio lì che dovrebbero essere abbattuti.
Marwa Karkouri 4d1s
LA TRACCIA
Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all’affermazione di un nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto “anagrafica”, o nazionale, ma che diventa ”planetaria” e quindi universale. Sviluppa l’argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell’affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di cittadinanza.
L’AUTRICE
Mi chiamo Karkouri Marwa, ho 18 anni e frequento il quarto anno del liceo scientifico delle scienze applicate Maxwell. Questo indirizzo mi offre molte opportunità per ampliare le mie
conoscenze scientifiche, che rappresentano una mia grande passione fin da piccola. Allo stesso tempo, però, riesce a dare spazio anche al mio lato più umanistico e creativo. Infatti,
amo leggere, viaggiare, guardare film e scoprire nuove culture: tutto ciò che mi permette di conoscere il mondo e le persone in modo più autentico. Nel tempo libero mi piace anche
passare momenti tranquilli con la mia famiglia o con gli amici più stretti, perché credo che i legami veri siano un rifugio prezioso per chiunque. Abito a Cologno Monzese con i miei genitori e con mia sorella minore, che sono una parte importante della mia vita. In casa siamo molto uniti e il sostegno che ricevo da loro è una forza che mi accompagna sempre.
Sono cresciuta tra due culture diverse: quella italiana, in cui vivo ogni giorno e quella delle mie origini,il Marocco, che porto nel cuore da sempre. Questa doppia identità mi ha insegnato a vedere il mondo da più prospettive, ad avere una mente aperta e a trovare ricchezza nelle differenze.